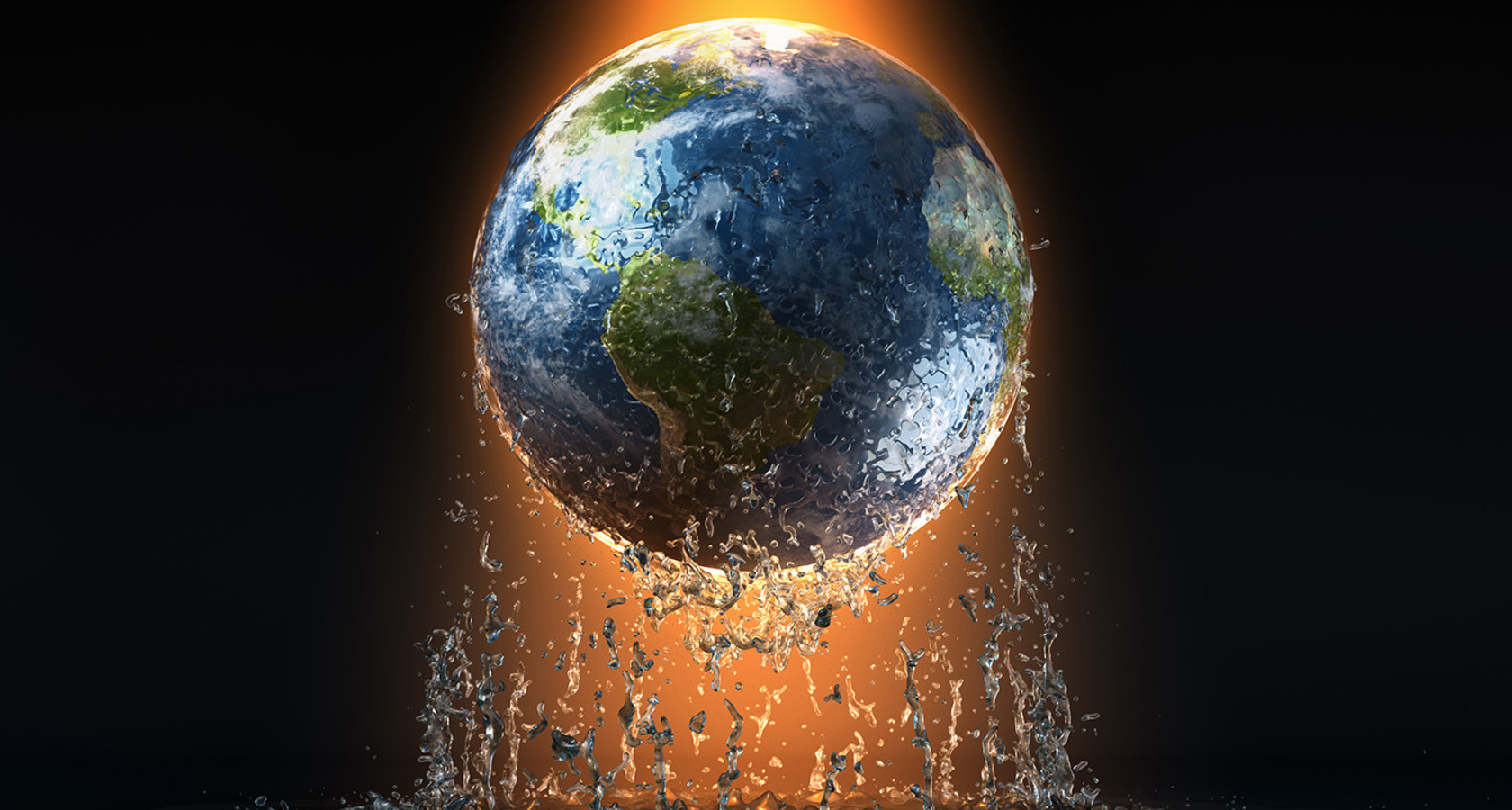
COMPROMESSO
La geopolitica del clima
Grattata via la vernice retorica della transizione ecologica, emergono grandi questioni afferenti al potere geopolitico, economico e tecnologico, che aiutano a comprendere le cause del compromesso al ribasso della COP26
11 minI
l 2020 è stato l’anno delle grandi promesse della politica mondiale sull’ambiente. I leader dei paesi occidentali hanno inglobato la transizione ecologica nei propri piani politici mentre cercavano di risolvere la crisi pandemica. Le due questioni si sono accoppiate, pur dando esito a risultati politici differenti. La pandemia ha spinto i governi verso un cambio di paradigma economico che prevede un maggiore interventismo statale, non soltanto dal punto di vista sanitario-emergenziale ma anche sul piano industriale e tecnologico. Nell’allargamento dei cordoni della borsa, e per legittimare la crescita ingente della spesa pubblica, sono state inserite le politiche green per fronteggiare il cambiamento climatico e sviluppare una economia più sostenibile.
Sul fronte ambientale, tuttavia, c’è un importante sfasamento tra retorica e realtà. Da una parte c’è l’invocazione dialettica dell’Apocalisse dei governanti occidentali, l’adesione alla formula promossa dai movimenti ambientalisti più radicali, l’offerta di ascolto ad una nuova ideologia, mentre dall’altra c’è la realtà del capitalismo e le pragmatiche esigenze della politica nazionale ed internazionale. Dove porta la strada dell’ecologismo? Per ora, con strategie simili in tutto l’Occidente, ha prodotto tassazione di attività inquinanti, incentivi per l’elettrificazione, investimenti in ricerca e sviluppo verso nuove tecnologie ecologiche, sussidi per fonti di energie alternative e rinnovabili. C’è in atto il tentativo, nel mondo occidentale in particolare, di sviluppare una transizione ecologica che per ragioni economiche e politiche non potrà essere drastica né dar corso all’ideologia apocalittica che infiamma la discussione mediatica. I governi si sono presto resi conto di due principali rischi derivanti dall’accelerazione ambientalista. Il primo è l’impatto socio-economico che una transizione ecologica troppo rapida e radicale può produrre, con effetti nefasti sull’occupazione e su fondamentali filiere industriali. Il secondo rischio è che una prolungata esplosione dei prezzi delle materie prime, alimentata anche dalle nuove tecnologie green, possa sfociare in una più ampia e generale spirale inflazionistica che metta a repentaglio il rilancio economico. Servono dunque gradualità e moderazione.

Molte speranze pochi impegni concreti
Questo indirizzo è stato certificato sia dal G20 che dalla COP26, dove l’agenda verde delle potenze dell’Occidente è stata costretta a fare i conti con la realtà del resto del mondo. Gli impegni concreti presi sul cambiamento climatico sono pochi, il vertice del G20 a Roma ha infatti dato poca fiducia alle grandi speranze riposte sulla COP26. Non c’è stato né un impegno esplicito sulla neutralità delle emissioni (carbon neutrality) dei grandi paesi entro il 2050 né una promessa di porre fine ai sussidi ai combustibili fossili, punto che era stato posto in cima alle priorità della COP26. Sebbene i leader del G20 si siano impegnati a fermare il finanziamento della produzione a carbone fuori dai propri confini nazionali entro quest’anno, essi non sono riusciti a raggiungere lo stesso accordo sulla produzione interna. Una situazione che lascia la porta aperta ad un reshoring degli impianti a carbone, in particolare per le economie da esso dipendenti, come la Cina e l’India, che potrebbero soffrire gravemente se attuassero una transizione energetica rapida.
Dato che l’82 per cento delle emissioni mondiali di gas serra sono state generate dai paesi del G20, con un ingente contributo di Cina, India e Stati Uniti, i risultati della COP26 non possono considerarsi né un successo né tantomeno un vincolo particolarmente rilevante per le potenze mondiali. Bisogna infatti rendersi conto che i maggiori “produttori di veti” sulle questioni climatiche sono anche i maggiori inquinatori del mondo a livello di emissioni (Cina, Stati Uniti e India) o i maggiori esportatori di petrolio (Australia, Russia, Arabia Saudita). Cina e Russia hanno spinto l’obiettivo della neutralità nelle emissioni di CO2 al 2060, e addirittura al 2070 nel caso dell’India. Siamo molto oltre l’obiettivo di metà secolo previsto dai lavoratori preparatori della COP26, una scadenza temporale ritenuta necessaria dagli scienziati per mantenere l’obiettivo di un aumento del riscaldamento globale di soli 1,5°C anziché 2°C come stabilito negli anni passati. L’Australia ha solo recentemente promesso la neutralità entro il 2050, sotto la crescente pressione degli altri governi occidentali, mentre l’Arabia Saudita ha puntato al 2060, ma senza rinunciare a mantenere il suo primato nella produzione di petrolio.
Le grandi assenti dal dibattito sul clima
Al di là degli impegni ancora relativamente tardivi per la neutralità climatica e della mancanza di piani concreti per l’utilizzo del carbone nel mix energetico, altre due importanti questioni sembrano essere finora assenti dalla discussione. Una è la decarbonizzazione delle supply chain globali, che rappresenta una grossa fetta delle emissioni di gas serra, basti pensare che otto supply chain chiave rappresentano da sole il 50 per cento delle emissioni annuali totali. Un potenziale percorso implicherebbe filiere più verdi ma anche più corte, con un’evoluzione verso un’economia regionalizzata, piuttosto che globalizzata, con ovvie e importanti conseguenze economiche e geopoliti- che. Il secondo punto mancante è una strategia per il prezzo globale del carbonio. Sebbene le possibilità di una stabilizzazione globale del prezzo delle emissioni di CO2 siano in aumento, con un nuovo sistema di scambio di quote di emissioni a livello nazionale che è stato varato dalla Cina nello scorso luglio e con una proposta di uniformazione del prezzo delle emissioni di carbonio a nuovi settori in Europa, il processo è ancora lungi dall’essere completo. Oltre ad aumentare l’estensione della stabilizzazione globale, basti pensare che gli Stati Uniti sono ancora silenti sul punto, servirà la capacità politica di coordinare questi sforzi sul piano globale, per evitare la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in altri luoghi del globo derivante dalla diversità della regolazione e dei prezzi. Difficile da realizzare in un mondo frammentato, diseguale, percorso da tensioni e interessi geopolitici profondi, mentre appare più probabile una regionalizzazione dei prezzi delle emissioni di carbonio nel medio periodo.

Altre tre questioni, inoltre, possono spiegare il bassissimo denominatore comune raggiunto sul clima al G20. In primo luogo, la crisi energetica sempre più grave in Europa e Cina, con i prezzi dell’approvvigionamento e di conseguenza delle bollette in grande crescita. Un problema politico difficile da gestire e che frena la corsa delle politiche green, le quali contribuiscono inevitabilmente alla crescita della domanda energetica e al rally dei prezzi. In secondo luogo, ci sono le ragioni politiche alla base del fallimento della COP26, come mostrato chiaramente in assenza di leader chiave come Putin e Xi, la cui cooperazione è cruciale nel raggiungere una soluzione coordinata al cambiamento climatico. La Russia non è importante solo per il cambiamento climatico, ma anche per appianare la crisi energetica europea, visto il ruolo fondamentale di Mosca come fornitore di gas. Terzo, la “spinta verde” sta bene al mondo della finanza che ha trovato un nuovo settore sul quale riversare il capitale con possibile vasta remunerazione. I grandi investitori sono disposti a finanziare tecnologie e nuovi business, ma non vogliono un’agenda di policy radicale che possa creare scompensi sul piano politico e sociale né politiche costituite quasi esclusivamente di iper-regolamentazione e sussidi né intendono correre il pericolo di far precipitare il sistema economico in una nuova crisi.
La lotta per la supremazia si tinge di verde
La questione climatica diviene allora, oltre che problema di taglio scientifico, proprio una questione geopolitica, attraverso la quale si snoda la competizione tra le potenze del globo. Gli Stati Uniti, come già accaduto dopo la Seconda guerra mondiale, spingono per la costruzione di un nuovo complesso militare-industriale-tecnologico e le politiche green rientrano all’interno di questo progetto. La canalizzazione di risorse pubbliche e private da parte del governo americano verso nuove tecnologie più efficienti e meno inquinanti è parte della strategia per competere con la Cina. Una superiorità sul piano della tecnologia industriale, infatti, è determinante soprattutto se, come notato di recente da Henry Kissinger, siamo al principio di una nuova Guerra fredda. Il “programma verde” è la cornice ideologica e cosmetica sotto la quale si cela la lotta per la superiorità economica e tecnologica nei confronti di Pechino. Il resto del mondo occidentale segue la propria potenza capofila, anche pur sacrificando, soprattutto in Europa, qualcosa sul piano industriale e occupazionale. Non è un caso, di conseguenza, che la Cina cerchi di frenare questa corsa e provi a sparigliare la competizione su altri fronti, da quello militare a quello digitale pur senza rinunciare ad un massiccio processo di elettrificazione. I cinesi hanno accettato il nuovo canone che informa lo sviluppo economico e tecnologico, ma vogliono giocare con i propri ritmi e le proprie regole. E, come loro, tutte le altre grandi potenze mondiali non occidentali.
Non si può dunque comprendere il compromesso molto al ribasso della COP26 se non si considerano tutte le variabili che girano intorno e soprattutto sotto alla questione ideologica. Grattata via la vernice retorica della transizione ecologica, restano in campo grandi questioni afferenti al potere geopolitico, economico e tecnologico. E come sempre questa seconda dimensione si gioca su strategie e compromessi che travalicano le novelle dei buoni propositi morali e le utopie movimentiste.

